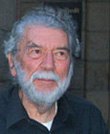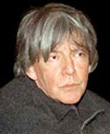L’INDUSTRIA NON TOGLIE LA LIBERTÀ DEL DESIDERIO

A proposito del tema di questo numero della rivista, La
necessità del superfluo, il 15 marzo scorso l’astronauta Paolo Nespoli ha
tenuto una conferenza alla SIR. Era un incontro necessario o superfluo? Paolo
Nespoli, ingegnere e maggiore dell’aeronautica, ha partecipato alla missione
militare in Libano ed è stato nello spazio tre volte: nel 2007 con la missione
Space Shuttle Discovery STS-120 (USA), nel 2010 con la missione Soyuz TMA-20
(Russia), diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, con 157 giorni di
permanenza nello spazio, e infine nel 2017 con la missione Soyuz MS-05 (Russia),
sempre diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, con 139 giorni di permanenza
nello spazio. Per noi è stata un’occasione d’interesse culturale, che ci ha
consentito d’indagare quali siano le sfide e le motivazioni che stanno alla
base del viaggio spaziale.
Inoltre, attraverso il racconto di aneddoti curiosi e
divertenti, l’astronauta ha illustrato le principali differenze tecnologiche,
organizzative e culturali tra l’approccio americano e quello russo.
Di primo acchito, un incontro come questo sembrerebbe non
portare alcun utile diretto all’azienda. In realtà, ci siamo resi conto che,
nei giorni successivi, molti collaboratori che avevano partecipato alla
conferenza continuavano a meditare sulla necessità di un approccio pragmatico
al lavoro e alla ricerca delle soluzioni. Nespoli stesso aveva elogiato
l’importanza dell’essenzialità, al fine di evitare inutili complicazioni, un
criterio che sta alla base dell’intero programma spaziale russo. “Ciò che non
c’è non si rompe” è la regola primaria della filosofia ingegneristica
sovietica; gli americani, al contrario, sono naturalmente portati alla
ridondanza estrema dei sistemi.
Rientra nella tradizione di SIR organizzare attività culturali
- come la conferenza privata di Nespoli - che non siano strettamente inerenti
al nostro settore. La lettura, per esempio, anche riguardo a temi che esulano
dalla robotica, è sempre stata promossa da mio padre, Luciano Passoni. Quando scopre
un libro interessante, di solito invia una mail ai collaboratori per consigliarne
la lettura oppure ne acquista una ventina di copie per regalarle a chi ama
leggere. Tra l’altro, è autore di due libri: L’uomo dei robot, la sua
autobiografia, e Il tramonto, in cui, poco prima che scoppiasse la crisi
del 2008, rivolgeva alla politica un accorato appello affinché fossero poste le
condizioni necessarie al rilancio dell’industria nel nostro paese.
Noi non ci siamo mai chiesti se il pensiero fosse necessario
o superfluo.
Costruiamo sistemi robotizzati, siamo tecnici e non
filosofi, eppure constatiamo che nessuno può fare a meno del pensiero, della
cultura e della riflessione.
L’incontro con Nespoli può essere utile per farci capire
quanto siano ridondanti e dispendiosi gli scambi di mail, di messaggi o di
telefonate finalizzati a documentare ogni singolo passo nello svolgimento del
proprio lavoro, un modo molto costoso per sbarazzarsi di ogni responsabilità. È
una pratica assurda che porta a uno spreco inaudito di tempo, di risorse e di
energie, oltre a diminuire l’efficacia produttiva dell’azienda.
Quindi, la ridondanza non è necessaria, mentre il
superfluo sì, se per superfluo s’intende tutto ciò che di solito viene considerato
inutile, se non dannoso, in quanto non produce i cosiddetti “beni di prima
necessità”. L’ideologia della decrescita felice, per esempio, attacca l’industria,
ritenuta responsabile d’indurre falsi desideri di “beni superflui”, che non
risponderebbero ai cosiddetti “bisogni reali dei consumatori”… Naturalmente
l’industria persegue i propri interessi, ma va anche ricordato che proprio
dall’industria sono nate quasi tutte le innovazioni. Pensiamo allo smartphone:
quando è uscito forse era superfluo, ma poi ci ha aperto nuovi orizzonti,
permettendoci di fare cose prima impensabili; da superfluo è infine divenuto
necessario. Lo stesso si può dire di tutte le opportunità che le tecnologie
digitali hanno concesso a paesi fino a poco tempo fa esclusi dall’economia
globale.
Alec Ross, nel suo libro Il nostro futuro, nota
che in un continente come l’Africa, per esempio, le tecnologie digitali, saltando
a piè pari tutti gli stadi precedenti, hanno contribuito a migliorare le condizioni
di vita di milioni di persone. In Pakistan, dove le donne non hanno nemmeno diritto
al voto, l’imprenditrice Maria Umar, con un computer, incominciò a lavorare per
alcune aziende degli Stati Uniti e, due anni dopo, costituì la Lega Digitale
delle Donne che oggi ha una rete con centinaia di freelance.
Questa è la prova che l’industria non toglie la libertà del
desiderio: dobbiamo anzi essere grati se esistono persone che s’ingegnano
continuamente per fare avanzare la tecnologia e aumentare la qualità della
nostra vita. Mio padre ha fondato la SIR proprio con questa missione: costruire
robot e impianti di automazione che eliminassero il più possibile i lavori pesanti,
ripetitivi e noiosi, affinché l’uomo potesse dedicarsi ad attività di maggiore
soddisfazione.
Gli attacchi all’industria e le proposte di decrescita
felice non vengono certo da chi usufruisce dei prodotti della civiltà
industriale: soltanto chi non ha esperienza della qualità di vita che abbiamo
raggiunto può criticare e attaccare il mondo produttivo. Spesso questi attacchi
sono basati esclusivamente sull’invidia sociale o sulla bramosia di distruggere
ciò che si pensa di non poter ottenere. Ma l’invidia sociale ha vita breve, non
ha nessun potere di fermare la trasformazione in atto e d’interrompere il gioco.
Tuttavia, la sociologia spaccia i suoi slogan
sull’economia circolare e la sostenibilità dalle cattedre di molte università italiane,
dopo essersi nutrita alle fonti di quelle francesi. Purtroppo, questi slogan arrivano
anche in alcune aziende, che ne fanno argomenti principe dei loro storytelling.
Noi italiani abbiamo una particolare predisposizione
all’assorbimento acritico di tutto ciò che viene da altri paesi, senza
valutarne gli effetti. Sulla sostenibilità energetica, per esempio, ci sarebbe
molto da dire: apparentemente, è tutto facile e lineare. In una grande casa automobilistica
che ha investito in un numero elevato di sistemi sostenibili, si è provato ad
alimentare la fabbrica esclusivamente con tali risorse. La prova è stata
effettuata al sabato, quando gran parte delle macchine utensili e le linee di
fonderia erano spente, e con un’esigua percentuale di personale presente. Sono
riusciti ad andare avanti qualche ora. Ma cosa accadrebbe se l’esperimento
fosse svolto di lunedì, quando la fabbrica lavora a pieno ritmo? La risposta è semplice:
utilizzando solo fonti rinnovabili, la produzione non sarebbe possibile.
Occorre ammettere che attualmente, per problemi di natura non ideologica, bensì
tecnologica, la sostenibilità non è sostenibile. Anche l’auto elettrica, se
fosse diffusa capillarmente in ogni famiglia, non sarebbe applicabile:
rappresenterebbe anzi una fonte d’inquinamento maggiore dell’auto tradizionale,
considerando che non basterebbero le energie rinnovabili a produrre l’enorme
surplus di corrente indispensabile a un parco macchine come quello attuale. Si
dovrebbe necessariamente incrementare la produzione di energia utilizzando il
carbone, il petrolio, l’atomo e le risorse idriche, tenendo però in
considerazione il fatto che le centrali idroelettriche, anche se poco
inquinanti, non si possono installare ovunque, perché non sempre la morfologia
e la struttura delle valli o dei corsi d’acqua lo permettono.
È indiscutibile che il mondo vada ormai in direzione
dell’elettrico, ma attualmente abbiamo ancora notevoli problemi tecnologici che
saranno risolti solo nel lungo periodo. Si consideri inoltre che molto spesso
il “mercato della sostenibilità” è drogato da incentivi che alterano la
razionale analisi dei costi e benefici.
Per quanto riguarda l’economia circolare, infine, è troppo
facile asserire che non devono esserci sprechi e che tutto deve essere
riciclato. Per riciclare in modo corretto, occorre mettere in atto una serie di
attività che presentano costi elevati, sempre ponendo attenzione al rischio che
tali procedure possono inquinare più di prima.
Oggi, in alcuni settori, le “fabbriche intelligenti”
utilizzano gli scarti di produzione al fine di evitare l’immissione di rifiuti
nell’ambiente. Chiaramente, non ha senso disperdere nell’ambiente materiali che
possono essere riciclati. Ma perché dovremmo definirla economia circolare? In
pratica si tratta di una pura e semplice limitazione degli sprechi, attività
economica che ogni buon imprenditore e ogni buon padre di famiglia dovrebbe fare.
SIR ha lavorato a un progetto di ricerca europeo, denominato
Areus, al quale hanno partecipato importanti università e partner industriali.
Sono stati sviluppati nuovi metodi di progettazione e gestione delle celle
robotizzate al fine di ridurre il consumo energetico mantenendo la medesima produttività
e qualità di lavorazione.
Uno degli obiettivi specifici di ricerca nell’ambito di
Areus riguarda il recupero di energia dai movimenti dei robot: l’attività
produttiva comporta elevati consumi energetici, amplificati dalle inefficienze
intrinseche delle macchine. Quando si utilizza un robot, una considerevole
quantità di energia viene dispersa nelle fasi di accelerazione e frenata.
Perché, quindi, non applicare ai robot lo stesso concetto utilizzato nelle auto
elettriche, dove l’energia dissipata in frenata viene recuperata per ricaricare
le batterie? Grazie all’introduzione sui sistemi robotizzati di tecnologie simili
al KERS (Kinetic Energy Recovery System, sistema di recupero dell’energia
cinetica), usato anche in Formula 1, è possibile recuperare il 20-30 per cento
dell’energia, che potrà essere reimmessa nella sottorete aziendale affinché le
macchine possano usufruirne. Se immaginiamo uno stabilimento automotive, che
soltanto nell’assemblaggio della scocca e del telaio di un’auto impiega un
migliaio di robot 24 ore su 24, è facile comprendere cosa significhi
risparmiare una percentuale così considerevole.
Abbiamo eseguito anche opportune prove per uno sfruttamento
più consono della gravità: il robot consuma più energia nei movimenti verso
l’alto piuttosto che in quelli verso il basso, nel quale è ovviamente aiutato
dalla gravità stessa. Programmando le sequenze dei movimenti in modo da limitare
le salite inutili e mantenendo i motori al minimo durante le discese (se
ovviamente il tempo ciclo richiesto lo permette), si ottiene un ulteriore beneficio
in termini di energia risparmiata.
L’applicazione di queste tecnologie porta a una maggiore
efficienza e a minori costi, ma per cortesia riferiamoci a queste strategie
utilizzando il loro vero nome: non economia circolare, bensì riduzione oculata
degli sprechi.