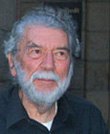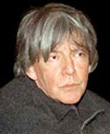LE TRE USURE

Lo storytelling del politicamente corretto inneggia all’importanza dell’utile:
fioccano gli inviti a fare qualcosa di utile, per se stessi e gli altri, o a
rendersi utile, collaborando per il bene comune. I più audaci invitano a mirare
all’utile, purché, beninteso, non contrasti con l’etica sociale e non sia
confuso con il profitto, cui viene quasi sempre attribuito l’aggettivo “ingiusto”,
soprattutto se si tratta di utili d’impresa. L’importante è che non ci sia
qualcosa di inutile o di inutilizzabile: le campagne contro lo spreco, così in
voga, esigono che le cose siano utili, utilizzate nel modo migliore e
soprattutto riutilizzabili. L’imperativo è riciclare, rimettere in circolo,
rigenerare. La società circolare non ammette il resto, l’eccedenza, il superfluo:
tutto deve essere finalizzato all’utilità sociale, intesa come bene comune.
Ciascuna cosa deve risultare utile, viene legittimata in un’economia del
negativo, chiamata una volta ottimismo della volontà e oggi ragione sufficiente:
dall’ignobile tratta degli africani, che viene giustificata come operazione
umanitaria e apportatrice di risorse, alla legalizzazione dell'eutanasia, imposta
in nome della libertà di scelta, la libertà di morire.
Nell’ideologia della società circolare, fondata sul relativismo,
l’utile è quel che si può usare, e che viene usato in modo corretto, cioè
secondo un fine corretto. Così il finalismo, la causa finale di Aristotele,
prende il posto dell’utile: diventa utile quel che serve al fine. E vana
risulta la dicotomia tra il fine intrinseco nella cosa e il fine stabilito
dalle convenzioni: cancella la constatazione che anche quel che è creduto proprietà
dell’essere è una convenzione, credenza o immaginazione che sia.
La questione è che valutare l’utilità dei nostri atti rispetto a un
fine procede dall’idea di conoscenza: conoscenza dei mezzi, delle capacità,
degli obiettivi, ovvero l’idea di sapere già da dove si venga e dove si debba
arrivare. Da qui lo scacco del finalismo: presumere di sapere come e dove
debbano andare le cose porta a escludere quel che non è previsto da questa
presunzione, dunque l’anomalia, l’abuso, la varietà, la differenza, l’invenzione,
la novità. Come pervenire all’utile escludendo queste prerogative del viaggio
di ciascuno e dell’impresa? Questa utilità sarebbe la morte: utilità della
morte, funzionalità della morte. Che cosa indica la spettacolarizzazione della morte
dei migranti o delle vittime del terrorismo, se non che la morte è utile, funzionale
alla circolarità? Un’impresa non può giungere al profitto se entra in questa
circolarità, se finalizza ogni suo atto per un fantasma di morte. Il progetto e
il programma non servono per finalizzare l’attività, occorrono perché la
ricerca e il fare dell’impresa e di ciascuno si scrivano, proprio avvalendosi
dell’improbabile e dell’imprevedibile.
“Meditare su ciò che è utile è il più sicuro degli indugi”, scriveva
il drammaturgo romano Publilio Siro. Nessuno può rappresentarsi da dove viene l’utile,
né come raggiugerlo, né quale è stato o quale sarà. Nulla è mai detto, nulla è
mai fatto. È utile quel che non è stato detto, è utile quel che non è stato
fatto. L’utile non è né il bene né il condivisibile – come nota nel suo intervento
Bruno Conti –, non è un fine, proviene dal dire e dal fare: l’utilità è
narrativa, dunque pragmatica. Questo dunque indica che il fare non prescinde
dalla parola, esige il racconto e giunge all’utile quando il racconto si scrive.
Per questo – come nota Antonella Silvestrini –, il racconto non può
ridursi allo storytelling, che è descrittivo, persuasivo, finalizzato alla
riuscita come affermazione di sé o dell’Altro, per cui deve soddisfare il senso
comune, il sapere comune e l’opinione comune. Se nulla è mai detto e nulla è
mai fatto, il racconto che giunge all’utilità pragmatica poggia sul sogno e
sulla dimenticanza, non sul realismo o sull’altra sua faccia, l’idealità. Nessun
progetto e nessun programma possono prescindere dal sogno e dalla dimenticanza:
cedere sul racconto, cedere sul sogno e sulla dimenticanza sbarra la via
dell’utile. E della sua punta, il futile.
Al conto della ricerca che si scrive e al racconto dell’impresa che
si scrive, e scrivendosi giunge all’utile, giovano la metafora, la metonimia e
la catacresi, le tre utilità della parola. Esse non sono concrete né
spirituali, attuano tre usure che ogni potere cerca di condannare e di punire
perché non sono finalizzabili. Per questo il discorso giudiziario, che è
strumento della società penitenziaria – perché gestisce gli umani attraverso
gli istituti della vendetta, della colpa e della pena – considera false e
ingannevoli la metafora, la metonimia e la catacresi e le sottopone al
misurabile e al contabile. Eppure, proprio la catacresi (dal greco catachresis,
abuso) indica quanto l’utile pragmatico non sia misurabile o calcolabile, sia abutile:
il fare è la struttura per abuso, come struttura dell’Altro, è struttura
narrativa, è struttura del racconto, è struttura con cui l’impresa si scrive. E
gli utensili di cui ciascuno si avvale, nel lavoro, nell’arte e nell’impresa,
sorgono dalla catacresi, dall’abuso linguistico: gli ordini professionali e
confessionali sono deputati a combatterlo, ma invano.
Che nella metafora, nella metonimia e nella catacresi si tratti di
usura indica come esse non possano prescindere dalla moneta e dalle sue virtù. Punto
di astrazione, garante dell’economia e della finanza, la moneta non si usura, è
condizione delle tre usure. Inafferrabile, la moneta è simulacro che l’economia
politica non riesce a padroneggiare. Simul è con, il con della
condizione, non della comunità ideale e dell’accomunare. La moneta non
accomuna, non circola e non è circolare, è condizione della differenza e della
varietà: oggetto dell’identificazione, non è divisa né condivisa, per questo
non riesce a garantire né l’unione né l’unità, come indicano le vicende
dell’Europa. Gli interventi di Tomaso Freddi e di Giovanni Giorgini evidenziano
che gli scacchi in cui si sono imbattute le burocrazie europee dipendono
dall’avere imposto un’unità monetaria, un’Europa dell’unione anziché della
differenza e della varietà, un’Europa dell’unificazione, funzionale alla
società circolare, anziché dell’integrazione, ovvero, secondo l’etimo di
integrazione, un’Europa cattolica.