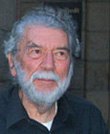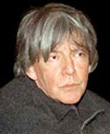ALIBI

“Me ne vado,
la mia vita è altrove”. “Ero stanco dell’Italia, ora me ne sto altrove”. Andare
altrove, starsene altrove. Traslocare, addirittura delocalizzare. “Qui in
Italia non si può più lavorare, occorre andare altrove, delocalizzare la
produzione”. Chi trasloca, chi delocalizza: si tratta sempre di luogo, questo
luogo, un altro luogo, il luogo presente, il luogo che conosco già. La
delocalizzazione, volgendo una questione di struttura e di direzione d’impresa
in problema di luogo, presunto svantaggioso, mantiene l’ideologia del
localismo, con l’idea di alternativa, e manca l’internazionalismo,
indispensabile per l’impresa.
Ma dove
stare, dove andare? In latino, “dove” è ubi.
Parlando, il dove non è il luogo. “Dove stai?” non indica un luogo, “dove” è un
punto: “Da dove vengono le cose?”. Ma “dove” è anche un contrappunto: “Dove
vanno?”. Questo dove, questo punto e contrappunto, che insiste nel racconto, è
illocalizzabile, è condizione di un itinerario narrativo, non spaziale.
L’itinerario di ciascuno, dell’impresa, della famiglia, è narrativo, si intesse
nel racconto. Raccontando, il dove non fissa un luogo, magari d’origine, ma
indica l’assenza di luogo nella parola, la non presentificazione del punto e
della struttura. La scontentezza, e persino il lamento, enunciano l’istanza del
dove e dell’altrove, non sono la prova di un bisogno di fuga o di abbandono.
“Adamo, dove
stai?”. Se Adamo risponde: “Sono altrove”, crede nell’alternativa, è pronto per
il precipizio, per la caduta. Una caduta senza punto, una caduta perché il
paradiso, il giardino, in cui le cose si fanno secondo l’occorrenza, venga
negato, divenga terrestre. Il paradiso non è terrestre, ma occorre l’idea di
caduta perché possa diventarlo. E, con la caduta, anche la terra diventa
terrestre, una terra senza cielo, una terra in cui cadere che, come diceva
Platone, diventa prigione. Ciascuna cosa diventa prigione, tolta l’occorrenza e
senza più avvenire. Quando il dove risulta prigione, ognuno vuole andare
altrove, cerca l’evasione.
Se il dove
non è un luogo, anche l’altro dove, l’altrove, non è un altro luogo, un luogo
alternativo, non è spaziale. La struttura della parola, ma anche la struttura
di ciascun dispositivo esigono l’altrove, in latino alibi (da alter ubi), che
non ha da essere rappresentato, altrimenti diventa alibi sociale, quello per
cui ognuno va altrove, va di qua, va di là, va dove gli pare e dove gli piace,
evade, si diverte, si avverte, si converte.
Alibi.
Quando noi crediamo di essere nel posto giusto o in quello sbagliato,
nell’unico luogo possibile o nel luogo in cui non vorremmo essere, togliamo,
idealmente, l’alibi, l’altrove, e allora le cose non si scrivono, ci restano
appiccicate, ci invischiano, ci sommergono. L’altrove nella parola è quel che
consente che le cose che incontriamo nell’itinerario si scrivano. Senza
l’altrove, la struttura del labirinto, in cui si stabilisce la ricerca, non si
scrive, e allora, come il Minotauro, siamo invischiati in un labirinto
prigione, che ci intrappola. Senza l’altrove, la struttura del paradiso, in cui
dimora il fare, non si scrive, e allora, come Adamo, siamo rinchiusi nel
paradiso terrestre, da cui evadere.
Dicendo,
facendo, narrando, l’altrove del labirinto, che impedisce che la ricerca giri
in tondo, è l’economia, oltre la ricerca. L’altrove del paradiso, del fare che
impedisce che l’impresa finisca, è la finanza, oltre il fare. Con questi due
alibi, la ricerca e il fare, procedendo dall’apertura, si scrivono,
l’itinerario si scrive, risultando narrativo, non reale o ideale. Per questo
con l’economia e la finanza, che non sono luoghi né fatti perché non
prescindono dalla narrazione, nessuno ha alibi da accampare, dunque non ha
bisogno di andare altrove, né di un’alternativa. Senza gli alibi della parola,
quindi l’economia e la finanza narrative, abbiamo la rovina o il fallimento
dinanzi e allora pensiamo che occorra scappare, pensiamo che tutto crolli o
vada in mille pezzi, esploda o imploda.
L’esperienza
esige che ciascuno non rappresenti l’altrove, prima di tutto nell’interno o
nell’esterno, per cui ci sarebbe chi è dentro e chi è fuori, chi è avanti e chi
è indietro. Se l’esperienza procede dall’apertura, non c’è modo di localizzare
il dentro e il fuori: ciascuno è interlocutore, ciascuno ha la chance di
divenire caso di qualità. Qui e ora, hic
et nunc, la struttura dell’atto di parola, non il presente.
I due alibi
impediscono che ci perdiamo e che ci abbandoniamo, che smarriamo la bussola o
che andiamo fuori rotta. La cifrematica, la scienza della parola, indica che la
direzione richiede la bussola della vita, l’istanza della qualità. Qualità
intellettuale, che poggia sul cervello come dispositivo di direzione e di
regia, non sugli standard e sulla condivisione. La condivisione esige una
realtà che si fondi sull’idea di sostanza, non la realtà intellettuale – come
nota in questo numero Ruggero Chinaglia – in cui ci imbattiamo con l’analisi,
la narrazione, la lettura. L’istanza della qualità intellettuale, della qualità
della vita, non abbisogna che la salute di ciascuno, ma anche dell’impresa,
dipenda dalle sostanze: l’istanza della qualità, la bussola della vita è la
salute stessa, istanza con cui la vita diviene valore assoluto, non si limita
all’idea di bene e di benessere. Perdere la bussola rincorrendo il benessere,
costruendosi alibi per evitare il disagio, il lutto, il dolore, comporta
smarrire la direzione, ma anche perdere la salute. L’immunità non si riduce al
sistema immunitario, esige la narrazione che dissipa i ruoli sociali, le coppie
dell’intersoggettività, come possiamo leggere nell’articolo di Antonella
Silvestrini. La salute non è un diritto né una condizione, è istanza di qualità
della vita, quando il racconto, poggiando sull’immunità, giunge alla
comunicazione e l’itinerario approda alla sua cifra.