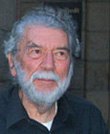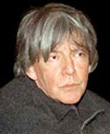L'INDUSTRIA DELLA PAROLA PER L'AVVENIRE DELL'EUROPA

A proposito
del ruolo dell’Europa nel pianeta e della politica da adottare per vincere le
sfide della globalizzazione, anche uno dei massimi esponenti della BCE (Banca
Centrale Europea) si limitava a ripetere un luogo comune pacifista: “La nostra
missione nel mondo è quella di rappresentare un potere gentile”, intendendo
dire, come nota Antonio Baldassarre in questo numero, che siamo un potere che
vuole la pace e non la guerra. Da chi sta ai vertici di un ente che interviene
in modo determinante in materia di economia e di finanza in tutti i paesi
dell’Unione ci si aspetterebbe quanto meno un accenno alla strategia economica
e finanziaria che si vuole mettere in atto, ossia a quali sono i settori e le
attività che si vorranno favorire nei prossimi dieci anni, in virtù del fatto
che saranno tali attività a costituire il nostro specifico rispetto a altre
aree del pianeta e a consentire quindi di raggiungere risultati soddisfacenti
per l’avvenire.
Ma,
evidentemente, non è un caso se il referendum sulla Costituzione europea viene
inteso come una questione ridotta banalmente al ritornello: “Europa sì, Europa
no”.
Dimenticando
l’essenziale: quali sono le radici culturali e artistiche dell’Europa e come
instaurare dispositivi perché le cose che si fanno, da qui ai prossimi dieci,
venti, trent’anni, vadano in direzione della qualità.
Dimenticando
che le radici culturali e artistiche dell’Europa non sono nell’illuminismo, ma
nel rinascimento. E lo statuto intellettuale di ciascuno, statuto che occorre
instaurare perché il viaggio della vita sia in direzione della qualità, si
avvale dei testi di Leonardo, Machiavelli e Ariosto. Per questo l’università
internazionale del secondo rinascimento – università non conformista, che non
porta alla routine o al sistema – non parte dalla separazione tra lavoro
manuale e lavoro intellettuale, tra il poeta e il banchiere, tra l’artista e
l’imprenditore. In questa università, ciascuno interviene, fa e scrive secondo
l’occorrenza. Non fa esercitazioni ma esercizi, esercizio d’intelligenza,
ginnastica intellettuale, s’industria e aguzza l’ingegno perché le cose
giungano alla riuscita. E il calendario e lo scadenziario sono ricchissimi di
date e di avvenimenti. Dal 5 febbraio 1973, l’esperienza del secondo
rinascimento – esperienza originaria ciascun giorno, mai basata sul glorioso
passato o sulla promessa di un radioso avvenire – consente, con i suoi
dispositivi, a ciascuno di acquisire strumenti essenziali per l’industria della
parola, quella industria che, come afferma Armando Verdiglione, “deve essere la
proprietà della vita per ciascuno”. E i dispositivi sono tanti e altri possono
costituirsi, perché tanti sono i prodotti dell’esperienza incominciata
trent’anni fa: la cifrematica, i libri della casa editrice Spirali, le opere d’arte
del Museo del secondo rinascimento, i congressi internazionali, il
brainworking, i servizi della Villa San Carlo Borromeo.
Dispositivi
da cui è imprescindibile l’impresa, con il suo rischio di riuscita, che non è
mai pericolo di morte. Mai, in trent’anni, il movimento del secondo
rinascimento ha stabilito il suo programma a partire dalla lotta contro un
presunto nemico. Eppure, le occasioni per costituirsi come vittime
dell’inquisizione, con i suoi feroci attacchi a un’impresa libera e
assolutamente inedita, non sarebbero mancate, sopra tutto nella seconda metà
degli anni ottanta. La battaglia, invece, è sempre stata battaglia per la
riuscita, battaglia per la salute, senza alternativa tra il bene e il male,
l’amico e il nemico. Troppo facile dire di volere difendere la pace e poi
rappresentare l’Altro nel nemico o nello straniero che invade il territorio con
uomini e merci. Più difficile invece instaurare dispositivi intellettuali con
ciascuno, indipendentemente dal settore, dal paese o dalla religione da cui magari
ognuno crede di provenire. Restituire il testo anche di chi appare più lontano
dalle nostre radici culturali è il compito che spetta sempre più all’Italia e
all’Europa nel terzo millennio. Sta anche qui la tolleranza, nel formulare
ipotesi dell’avvenire che tengano conto delle varie istanze culturali che si
affacciano sempre più alle porte del Mediterraneo. Nessuna politica industriale
può inventare l’Europa senza questa tolleranza, che le consentirà invece di
divenire ancora una volta, come nel rinascimento, centro e crocevia di
differenti civiltà. Per questo occorrerà dare impulso a nuove vie di
comunicazione, come scrive Aurelio Misiti nel suo libro Il viaggio dell’avvenire (Spirali), anziché innalzare muri e
steccati contro l’invasione straniera. E se oggi le aree più avvantaggiate sono
quelle che attirano i maggiori investimenti, occorre chiedersi in che modo la
cultura, l’arte e il turismo che da esse procede – che darà nuovo slancio anche
ai settori connessi all’ospitalità – possono attirare capitali e divenire carte
vincenti per l’avvenire dell’Europa.
L’industria
della parola è stata inventata nel rinascimento, ma s’instaura ciascun giorno e
ha come condizione la voce, punto di astrazione e punto di oblio. È quella
industria che non si oppone alla natura, anzi, in seguito al rinascimento non
c’è più la dicotomia naturale/artificiale, proprio perché la natura e
l’industria sono natura della parola e industria della parola, anziché stati
dell’essere. E a torto c’è chi crede che la natura sia il regno della necessità
pragmatica e l’industria quello dell’astrazione pura. Il punto di astrazione è
la condizione dell’industria, ma non c’è nulla di più pragmatico
dell’astrazione. Ecco perché, nell’era del secondo rinascimento, risulterà
sempre più impossibile la separazione fra lo scienziato e l’imprenditore.