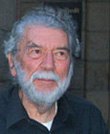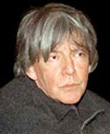CORPO-REO
Io non vado sulla vostra strada, dispregiatori del corpo! Voi non siete per me ponti verso il superuomo! (F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra)
È difficile trovare nella letteratura, scientifica, religiosa, filosofica un’elaborazione che si distanzi dall’idea del corpo corruttibile, in quanto al corpo, inteso come entità estesa e percepibile, vengono attribuite proprietà biologiche, meccaniche e fisiche. La stessa idea di decadenza, di mortalità sembra apparentemente confermare la sentenza del Fedone platonico, in cui è sostenuta la tesi del corpo come tomba dell’anima. Il corpo come prigione, il corpo del reato, l’invecchiamento del corpo, l’anima-lità del corpo: questi alcuni enunciati del luogo comune filosofico-biologico-scientifico.
La spazializzazione del corpo implica l’occupazione di un luogo, la mentalizzazione del corpo la sua abitabilità. La clonazione, partendo proprio dal principio di corruttibilità, fa il verso a Cartesio quando sostiene la possibilità di creare un corpo senza cervello, quindi senza anima, funzionale solamente al ricambio degli organi. Nelle Meditazioni metafisiche Cartesio sostiene che la res extensa e la res cogitans sono entrambe sostanze, ma di natura diversa e separata: il corpo è concepito come una macchina che si muove da sé, in modo automatico. Tutto ciò ha sortito teorie monistiche o dualistiche con soluzioni di compromesso. Non ultima quella di Marx, che capovolgendo l’idea di un’anima che dirige il corpo, considera con il suo materialismo i pensieri dell’uomo come diretta emanazione dei suoi comportamenti materiali. Già, proprio il comportamentismo del corpo ha dato la stura al filone esistenzialista fino a quello fenomenologico. Da Sartre a Merleau-Ponty, passando attraverso le Meditazioni cartesiane di Husserl, il corpo, spazializzato e temporalizzato, mantiene l’idea di una sua presenza come apertura al mondo dell’esperienza, con l’unico risultato di riporre la cosiddetta corporeità sulla carnalità fisica negando propriamente il gesto di Cristo; praticamente un carnevale perenne dove ognuno indossa l’abito della personalità che gli è più consona. Tutto ciò giunge fino all’estremo gesto dell’autoritratto impossibile, dove il chirurgo plastico, novello sarto procusteo, cuce e ricuce su misura un abito assolutamente impeccabile.
Come uscire da questi invischiamenti mondani e quindi fuori moda? Già con la psicanalisi Freud sostiene nella sua seconda topica che l’Io non è altro che una superficie corporea. In precedenza, quasi per un omaggio all’antichità, lo stesso Freud inventava la teoria duale della pulsione, situando quest’ultima tra lo psichico e il somatico. Tutto ciò nella vulgata lettura del testo di Freud, in assenza di analisi, ha costituito le teorizzazioni della psicosomatica con i suoi continui riferimenti sintomatologici. Ma il destino della pulsione è il rivolgersi verso la qualità, che con la psicanalisi incomincia a precisarsi come qualità della parola. Facendo un passo ulteriore, lungo la danza inaugurata da Zarathustra, la cifrematica qualifica che quello che gli umani chiamano corpo altro non è che immagine. Scrive Armando Verdiglione nel Leonardo da Vinci: “L’anatomia, che è della sembianza, procede dal rilievo, modo della giuntura e separazione, del corpo e della scena, perché le immagini si scrivano e si qualifichino. […] Dalla difficoltà, che è della parola, alla semplicità. La via della scrittura è la via della qualità, della cifra e dei suoi effetti di verità e di riso. Il corpo e la scena si combinano nella cifra.”
Come può l’immagine corrompersi se la combinazione del corpo e della scena sono originari nell’atto di parola? Il gesto di Cristo che innalza il pane dicendo “questo è il mio corpo, prendete e mangiate” implica già il dogma della transustanziazione, sancito poi dal concilio di Trento. Con Cristo il corpo — non più corrotto e corruttibile, non più (corpo) reo di chissà quali nefandezze — entra nella parola. Da dove vengono le cose è una prima interrogazione che Verdiglione rileva nel testo lucreziano del De rerum natura. Il dove, che non è un luogo, implica questa combinazione non più corruttibile, non più sostanziale del corpo e della scena. Questo dove non è origine, ma il punto che proviene dal corpo, questo dove sottolinea la condizione dell’itinerario. Scrive Verdiglione nel libro Il brainworking: “L’itinerario è anche combinazione e combinatoria, in quanto le cose procedono dal due. Il corpo e la scena si combinano nella cifra lungo il gerundio, vivendo, cercando, facendo”.