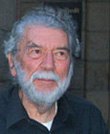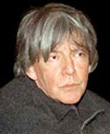IL DISPOSITIVO DI SANITÀ E LA STRADA DELLA SALUTE

Dal mese di giugno 2014 alcune
professioni di riferimento per la sanità e la salute in Italia sono state
oggetto di un cambiamento normativo che avrà effetti rilevanti sia per chi si
troverà a svolgerle sia per chi vi farà ricorso per avere risposte alle proprie
istanze di sanità e di salute. Il cambiamento riguarda la creazione di un nuovo
albo delle professioni sanitarie, comprendente diciassette tra le ventotto
riconosciute dal Ministero della Salute, e l’attribuzione a queste di nuove
prerogative di responsabilità, definendo i parametri procedurali e
professionali specifici. Si tratta per lo più di figure facenti già parte di
professioni del campo infermieristico e tecnico sanitario, da alcuni anni
arricchite da una formazione di profilo molto più alto, anche di ambito
universitario.
A una prima considerazione, sembra
un’iniziativa encomiabile, che riconosce dignità professionale a figure
essenziali, a volte quasi quanto i medici, per affrontare malattie o problemi
di assistenza. Così non viene più attribuito esclusivamente al medico il sapere
in materia di sanità e di salute, né le altre professioni sanitarie sono mere esecutrici
delle sue decisioni. D’ora in avanti, chi esercita una delle professioni del
nuovo ordinamento sanitario può divenire interlocutore diretto, per gli aspetti
concernenti la sua formazione specifica, di chi lo interpella su questioni di
salute. Il medico rimane la figura principale e definitiva di riferimento e di
responsabilità per la direzione della cura.
Tra le nuove figure di questo albo vi è
anche quella dello psicologo formatosi presso una facoltà di psicologia di
un’università italiana. L’inserimento dello psicologo fra le professioni
sanitarie è stato in discussione fino all’ultimo, perché la psicologia
professionale è una pratica che si rivolge a casi particolari, irriducibili
alla standardizzazione, in cui gioca un ruolo predominante la statistica. Da
anni ormai lo standard e la statistica sono i criteri fondanti le attuali
pratiche sanitarie in tutto il pianeta, al punto che si parla di “Medicina
delle prove d’efficacia”. E l’inserimento fra le professioni cosiddette
sanitarie sarebbe addirittura problematico se dovesse coinvolgere la
psicanalisi, che è “scienza del caso singolo”, come la definì lo stesso Freud.
Il problema sta proprio qui, nel sottoporre ciascun caso, di malattia o di
salute, al riconoscimento e all’osservanza di criteri di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione interdipendenti e sottesi da linee guida cui devono
attenersi tutti gli esercenti le professioni sanitarie. Sono criteri che
indubbiamente hanno consentito, insieme alle scoperte della medicina degli
ultimi decenni, un grande avanzamento della pratica medica e della sua
efficacia nel mantenimento di condizioni di salute, ma che non possono essere
applicati alla psicanalisi, e nemmeno diventare una camicia di Nesso della
stessa pratica. Come avevano previsto il grande immunologo e oncologo Georges
Mathé nel libro 1999. L’uomo che voleva
essere guarito e il sociologo Lucien Sfez nella Salute perfetta, oggi la raccolta dati e l’”inquadramento” dei
casi, secondo i principi sopra citati, rischia di occupare altrettanto tempo
della pratica di cura vera e propria. È un rischio noto a chi si occupa di
sanità e deve essere affrontato quotidianamente. Oggi chi entra in una
struttura sanitaria deve affrontare interviste per la compilazione della
cartella medica, poi anche di quella infermieristica, sempre più spesso di
quella psicologica, nelle strutture più grandi anche di quella sociologica. I
dati raccolti devono essere “incrociati” e diventare operativi seguendo
gerarchie di valutazione e linee guida. Ma le risposte a domande prefissate
escludono tanti elementi del racconto del paziente. In quanto responsabile
della qualità delle relazioni di una struttura sanitaria e delegato all’ultima
intervista al paziente al momento della dimissione, constato che, sempre più
spesso, oltre alla qualità percepita delle varie pratiche, quali igiene,
competenza, precisione, manualità e destrezza, risulta decisiva, nel valutare
gli operatori sanitari, medici, infermieri, tecnici, psicologi, la loro
propensione alla responsività, all’ascolto, alla considerazione di quanto viene
loro riferito al di fuori dell’intervista anamnestica, all’empatia dimostrata.
Queste virtù, un tempo essenziali nella pratica medica e importanti per
l’accettazione della cura, oggi sono forzatamente in declino per la complessità
attuale della “macchina” sanitaria.
Risulta allora indispensabile una nuova
assunzione di responsabilità da parte di ciascuno, quando si trova “paziente” o
“utente” di una struttura, per divenire interlocutore di ciascuna delle figure
sanitarie e per costituire con esse un dispositivo che non sia solamente di
delega. A questo proposito Sergio Dalla Val scrive nel capitolo “La strada
della salute” del suo libro In direzione
della cifra. La scienza della parola, l’impresa, la clinica: “Nella medicina
scientifica, non c’è il rapporto medico paziente stabilito dai protocolli, ma
un dispositivo di parola [...] in cui la conversazione procede dall’apertura”.