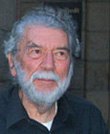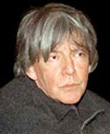L'INTEGRAZIONE E LA CONSULENZA CREANO LA DOMANDA NUOVA
In quasi trent’anni, il vostro studio si è cimentato con vari ambiti dell’ingegneria, tra l’altro, collaborando con il dipartimento di Scienze delle costruzioni dell’Università di Bologna nella ricerca sui materiali e sui sistemi diagnostici e dando un apporto alla realizzazione di strumentazione sensoristica da utilizzare su edifici e infrastrutture. Come si sta evolvendo la vostra attività nell’industria della diagnosi architettonica?
Oggi il nostro studio promuove un nuovo modo di fare ingegneria diagnostica: anziché limitarsi all’applicazione della sensoristica per la ricostruzione storica di ciò che ha portato a danneggiamenti o per il collaudo di nuove opere, l’ingegneria oggi deve assicurare un monitoraggio che diviene componente essenziale dell’opera stessa. La nostra diagnosi su edifici e infrastrutture, anziché interessarsi esclusivamente dell’evento e della sua gestione, contribuisce alla tutela e alla salute del patrimonio architettonico e urbanistico. È il risultato di anni di collaborazioni con la pubblica amministrazione, con società di gestione di strade, autostrade, ferrovie, con tutti gli operatori che hanno il compito di tutelare e possibilmente incrementare valore e sicurezza di immobili o addirittura di parti del territorio, e con le imprese che si occupano degli interventi di progettazione, costruzione e riqualifica. Oltre che nel perfezionamento delle tecniche d’ingegneria diagnostica, attualmente siamo impegnati in un’opera di costruzione di modelli per l’integrazione delle complesse esigenze di servizio, funzionalità e sicurezza della committenza, che gli imprenditori del settore edile devono gestire.
Offriamo supporto nell’implementazione di nuove forme contrattuali di tipo prestazionale, capaci di adattarsi in fase d’opera alle modifiche, ma anche alle stesse verifiche diagnostiche. Questi contratti dinamici prevedono sistemi grazie ai quali le parti si accordano nelle varie fasi di avanzamento dei lavori per evitare, come purtroppo frequentemente accade, che non si proceda al pagamento perché non si raggiunge il livello prestazionale richiesto o che i lavori vengano interrotti perché l’esecutore si accorge che non raggiungerà i risultati attesi. Bisogna garantire, attraverso controlli prestabiliti, l’assemblaggio delle lavorazioni, delle tecnologie e dei materiali, con la possibilità d’inserire sistemi progettuali applicabili in corso d’opera e quindi di ridefinire la procedura e il progetto stesso. Tra parentesi, per il collaudo in corso d’opera, un aspetto non secondario è l’integrazione del sistema diagnostico nell’opera, attraverso l’installazione di sensori e la predisposizione di accessi per diagnosi non distruttive. Abbiamo sperimentato tali nuove forme contrattuali soprattutto in casi di opere delicate per il valore strategico o per l’esigenza d’integrazione tra opera e ambiente o opera e città, come il nuovo ponte sul Po a Piacenza o la TAV. Questo nuovo approccio culturale, che non intende il “prodotto” come fine a se stesso, non è valido solo per l’edilizia, ma offre anche applicazioni utili per la creazione e il marketing di prodotti industriali o tecnologici, specialmente se destinati a integrarsi su reti, infrastrutture o attrezzature pubbliche esistenti. Si pensi all’introduzione, su un parco di mezzi pubblici, di nuovi sistemi di sicurezza per i passeggeri o di sistemi d’illuminazione per strade pericolose o per piste ciclabili.
La complessità che avete riscontrato nei processi e nelle esigenze dell’edilizia è una complessità tecnica ma anche relazionale?
Lavorare con la pubblica amministrazione può aiutare a capire come si crea una nuova domanda, perché è già un fulcro d’integrazione di microeconomie ed esigenze della società, ma è possibile andare ben oltre i bisogni di base, anche se dobbiamo fare i conti con una cultura a tratti individualista, che lamenta la mancanza di risorse. Però la questione centrale resta quella che coinvolge le imprese: occorre creare una domanda più qualificata da un lato, ma dall’altro servono forme associative capaci di offrire livelli prestazionali molto elevati e allo stesso tempo di tutelare i propri interessi sul mercato, dal punto di vista legale e tecnico, con il coinvolgimento di equipe condivise di esperti in campo amministrativo, ingegneristico e anche finanziario. Questo tipo di esperienza offre spunti per nuovi modelli di business diffuso e di marketing in rete, perché l’integrazione può e deve realizzarsi anche fra imprese. Occorre rilanciare il concetto di alleanza, le reti e l’associazionismo, anche per andare oltre la tradizionale concezione di prodotto fine a se stesso, con il suo valore intrinseco. Recentemente, nel nostro intervento a un incontro promosso da Confcommercio Roma sulle ipotesi per rivitalizzare la microeconomia nell’edilizia, abbiamo sottolineato come una delle chiavi di tale processo sia la politica di recupero e riconversione degli spazi abbandonati o depressi all’interno della città, dove recupero non significhi solo qualità nella scelta dei materiali e delle tecniche per giungere a un optimum di prodotto: recuperare palazzi storici o spazi pubblici, senza aver prestabilito destinazioni d’uso, responsabilità e benefici, anche in termini di business, significa produrre cattedrali nel deserto. Un esempio riuscito d’intervento è invece il progetto Grandi Stazioni, a cui stiamo collaborando insieme ad architetti ed esperti di marketing. Con questo progetto, le stazioni diventeranno luoghi d’incontro tra cittadini e tra imprese e vetrine per grandi firme.
In conclusione, è sempre più chiaro come per la promozione della cultura e delle sue specificità occorra costruire una filiera che parta dall’obiettivo finale e si avvalga della grande varietà di arti e mestieri esistenti, superando la logica della spartizione e del conflitto, ma per questo occorrono strumenti e dispositivi di direzione per un’ingegneria del processo a carattere imprenditoriale.